![]()
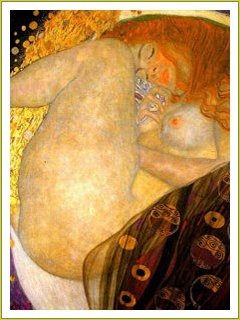
IL CASO CLINICO
Tante crisi, una cefalea
Marco Trucco, Centro Cefalee, Ospedale S. Corona, Pietra Ligure (SV) - ASL 2 Savonese
m.trucco@asl2.liguria.it
Introduzione
La signora C.L., 46 anni, giunge alla nostra osservazione per il riacutizzarsi di un “vecchio” mal di testa, di cui soffre periodicamente da circa 10 anni. Trattasi di una cefalea unilaterale localizzata in sede temporo-orbito-sovraorbitaria, a livello dell’ala del naso e dell’orecchio prevalentemente a sinistra, ma talvolta controlaterale (rispettivamente 70 e 30%).
Le crisi algiche sono dapprima di tipo trafittivo, di brevissima durata, poi di tipo urente nella stessa sede, di durata tra 120-180 secondi e frequenza fino a 30-40 crisi/die. Il dolore è associato ad importanti fenomeni autonomici omolaterali: lacrimazione, iniezione congiuntivale, ostruzione nasale, rinorrea, edema palpebrale, arrossamento della cute del viso, sudorazione profusa e tachicardia.
Le crisi hanno mostrato andamento ciclico, a cadenza inizialmente stagionale (primavera ed autunno), con periodi attivi di 4-5 giorni. Non sono certi i fattori di scatenamento degli attacchi.
Il motivo che ha giustificato il rivolgersi al nostro Centro Cefalee è rappresentato dalla persistenza, negli ultimi 5 mesi, di crisi cefalalgiche intense e frequenti, intervallate da un dolore di tipo tensivo: scarso o nullo beneficio avevano sortito l’assunzione, per sua volontà, di Nimesulide (100 mg x 3-4/die) e Metamizolo, così come il Litio carbonato (300 mg x 2) e l’ Indometacina (50 mg x 3), prescritti dal medico curante.
Anamnesi fisiologica e patologica remota
Non familiarità per cefalea. Nata pretermine da parto eutocico. Tre gravidanze, l’ultima delle quali caratterizzata da comparsa di diabete gravidico. Da circa un anno si segnala l’alternarsi di mesi in cui è presente amenorrea a periodi caratterizzati da elevata frequenza dei flussi (due in un mese). Fuma 20-40 sigarette/die. Sovrappeso. A 28 anni Tbc apparato genitale.
Iter diagnostico
La paziente è stata ricoverata presso la nostra Divisione di Neurologia. EOG ed EN nella norma. Esami ematochimici: lieve stato anemico migliorato spontaneamente.
TC cerebrale + TC ad alta definizione: otosclerosi della rocca petrosa con eburneizzazione della mastoide.
Rx colonna cervicale: riduzione della fisiologica lordosi, cervicoartrosi osteofitosica C5-C6. Conservati gli spazi intersomatici. Non segni di instabilità.
SPECT con Tc-99m HM-PAO: regolarità di perfusione delle strutture cerebrali esaminate.
RM encefalica con studio mirato sull’ipofisi + mdc: focale iperintensità in T2 e FLAIR nella sostanza bianca sottocorticale frontale e para-lateroventricolare sin. senza CE, attribuibile a sofferenza di origine vascolare.
Controllo routine ematochimica a circa 1 mese dalla dimissione: nella norma.
Opzioni terapeutiche
La paziente è stata inizialmente trattata con Zolmitriptan 2.5 mg con iniziale modesto beneficio, poi sospeso per intolleranza. Paroxetina 20 mg: inefficace. Nimodipina 20 mg x 3: inefficace, non tollerata per rash cutaneo. Verapamil ritardo 240 mg: inefficace e non tollerato. Prednisone 25 mg x 2: inefficace.
Una volta perfezionata la diagnosi, è stata prescritta Lamotrigina, inizialmente al dosaggio di 25 mg x 2/die per 2 gg. (inefficace), poi 50 mg x 2 per 4 gg. (riduzione intensità delle crisi), poi 125 mg/die per 5 gg. (scomparsa attacchi intensi e dolore intervallare, persistenza di isolati dolori di lieve intensità), in seguito 150 mg (scomparsa attacchi tipici, solo dolori istantanei - 1-2/die - per 1-2 settimane, in seguito completo benessere; alcuni attacchi isolati a distanza di 1-2 mesi). Dose 200 mg: efficacia completa. Non effetti collaterali.
Dopo circa tre mesi di terapia, si è ripresentata recidiva degli attacchi, per cui è stato associato Gabapentin a dosaggio crescente fino a 900 mg/die, con effetto completo e duraturo sulla sintomatologia, anche in questo caso senza eventi avversi degni di nota.
La paziente ha assunto la terapia prescritta per 6 mesi circa, con persistenza dell’efficacia terapeutica.
Conclusioni diagnostiche
La cefalea sopra descritta soddisfa i criteri diagnostici di una sindrome SUNCT.
Discussione
La paziente si era presentata alla nostra osservazione in seguito a marcato peggioramento della sintomatologia, dovuta a modificazione della scansione temporale degli attacchi dolorosi, che erano passati da un pattern episodico con brevi periodi attivi e remissioni di lunga durata ad un periodo attivo datante da cinque mesi, caratterizzato da crisi intense e pluriquotidiane.
La signora non si era rivolta al medico curante né ad alcun Centro Specialistico fino all’ultimo episodio. La diagnosi non è tuttavia stata emessa all’ingresso in reparto; tale ritardo ha comportato per alcuni giorni la prescrizione di terapie inadeguate quanto inefficaci.
L’osservazione di casi peraltro tipici associati a patologia intracranica ha reso necessaria l’esecuzione di una completa batteria di accertamenti di neuroimaging, risultati negativi o comunque non significativi per un nesso causale con la cefalea.
Il favorevole effetto terapeutico osservato con la Lamotrigina (e in seguito con l’associazione Lamotrigina-Gabapentin) non può essere attribuito ad una remissione spontanea, anche in considerazione dell’inefficacia di numerose altre terapie, compresa l’ Indometacina. I farmaci specifici, prescritti dopo il perfezionamento della diagnosi, non hanno provocato effetti indesiderati.
La Lamotrigina (LTG) è un potente inibitore dei canali del sodio con azione anti-glutammatergica. Nella profilassi delle cefalee viene principalmente impiegata nell’emicrania con aura ad elevata frequenza di crisi (15). Viene anche utilizzata nel trattamento di alcune forme di dolore neuropatico (neuropatia diabetica dolorosa, nevralgia trigeminale, dolore centrale post-ictus) al dosaggio di 200-400 mg, dopo titolazione, allo scopo di evitare rash cutaneo (16).
Il meccanismo d’azione attraverso il quale la LTG agisce nella sindrome SUNCT non è stato chiarito: la sua azione stabilizzatrice di membrana potrebbe contribuire a ridurre l’attivazione ipotalamica osservata in questa forma di cefalea, oltre ad una possibile azione diretta sul nervo trigemino, implicato nella genesi del dolore delle TACs.
Il suo impiego quale farmaco di prima scelta nella sindrome SUNCT, in monoterapia o in associazione a gabapentin, è ormai largamente acquisito.
LA SINDROME SUNCT
Trattasi di una condizione clinica descritta per la prima volta da Sjaastad et al. nel 1978 (1), meglio precisata da studi successivi (2-3), caratterizzata da attacchi di dolore cranio-facciale unilaterale, raramente con alternanza di lato, neuralgiforme o a carattere trafittivo o pulsante, di breve durata, generalmente di intensità elevata, accompagnati da intensi sintomi autonomici locali (iniezione congiuntivale, lacrimazione, rinorrea, edema/ptosi palpebrale) omolaterali al dolore, con tendenza a raggrupparsi in periodi di varia durata separati da intervalli liberi. La forma primaria è considerata di relativamente rara osservazione. E’ stata descritta una prevalenza nel sesso maschile (da 2:1 a 4:1); l’età di esordio sembra più comune dalla quarta decade in avanti, per quanto siano stati descritti quadri anche in età evolutiva.
La sindrome SUNCT nella sua forma più tipica è da considerarsi una cefalea primaria. Sono stati descritti in letteratura vari casi di sindrome SUNCT, anche a sintomatologia del tutto tipica, in associazione ad angiomi cerebrali, malformazioni intra- ed extracraniche, adenomi pituitari, neoplasie, traumi cranici ed oculari (4).
La sindrome SUNCT, ampiamente documentata prima dell’entrata in vigore della Classificazione ICHD-II, è stata inserita nella stessa al punto 3 (Cefalalgie Autonomico-Trigeminali), dato l’imponente corredo sintomatologico autonomico associato alle crisi. In Appendice è stata tuttavia inserita una forma analoga (SUNA: Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with cranial Autonomic symptoms), allo scopo di inserire casi a sintomatologia meno definita rispetto all’osservazione originale (5), a sua volta distinta in forma episodica e cronica. Tali forme sono state trattate in dettaglio in una review del 2006 (6), in cui si propongono alcune modifiche nei criteri diagnostici, che saranno sicuramente discusse nella nuova edizione della Classificazione.
In Tabella 1 sono riportati i criteri diagnostici per la SUNCT secondo la Classificazione ICHD-II. In Tabella 2 si riportano i criteri per la SUNA, come dall’Appendice.
La fisiopatologia della sindrome SUNCT è a tutt’oggi sconosciuta. Un lavoro di May et al. (7) tuttavia evidenzia attivazione del grigio ipo-talamico posteriore omolaterale al dolore in corso di un attacco spontaneo di SUNCT, osservato alla Risonanza Magnetica Funzionale. Tale reperto è analogo ad un dato dello stesso Autore, in corso di un attacco spontaneo di cefalea a grappolo (8). Studi successivi (9) hanno però evidenziato attivazione ipotalamica bilaterale o controlaterale al dolore.
Dall’epoca delle prime osservazioni, questa sindrome, descritta come particolarmente penosa e disabilitante per i soggetti affetti, si è manifestata refrattaria a qualunque terapia. Nel 1999 D’Andrea et al. (10) testarono l’anti-epilettico Lamotrigina su un caso di SUNCT, ottenendo una completa efficacia sulle crisi dolorose al dosaggio di 150 mg/die. Tale risultato è stato confermato su altri casi analoghi (11), a dosaggi fino a 400 mg/die. Altre osservazioni hanno evidenziato l’efficacia del Topiramato fino a 400 mg/die (9), del Gabapentin fino a 3600 mg/die (9; 12) e dell’Oxcarbazepina 600 mg/die (13). In casi refrattari a qualunque terapia farmacologica è stata effettuato trattamento con Deep Brain Stimulation a livello ipotalamico (14) o stimolazione del n. grande occipitale (9).
Tabella 1
Criteri diagnostici per SUNCT (3.3)
A. Almeno 20 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Attacchi di dolore unilaterale, in sede orbitaria, sovraorbitaria o temporale, trafittivo o pulsante, della durata di 5-240 secondi
C. Il dolore si associa a iniezione congiuntivale e lacrimazione omolaterali
D. La frequenza degli attacchi è compresa tra 3 e 200 al giorno
E. Non attribuita ad altra condizione o patologia
Tabella 2
Criteri diagnostici per SUNA (A3.3)
A. Almeno 20 attacchi che soddisfino i criteri B-E
B. Attacchi di dolore unilaterale, orbitario, sovraorbitario o temporale, trafittivo o pulsante, della durata da 2 secondi a 10 minuti
C. Il dolore è accompagnato da uno dei seguenti sintomi:
1. iniezione congiuntivale e/o lacrimazione
2. congestione nasale e/o rinorrea
3. edema palpebrale
D. Gli attacchi si presentano con una frequenza ≥ 1 al giorno per più della metà del tempo
E. Gli attacchi scatenati da aree “trigger” non sono seguiti da un periodo refrattario
F. Non attribuita ad altra condizione o patologia
A3.3.1 SUNA episodica
A. Attacchi che soddisfino i criteri A-F per A3.3 SUNA
B. Almeno 2 periodi attivi di durata da 7 giorni a 1 anno (se non trattati), separati da periodi di remissione liberi dal dolore di durata ≥ 1 mese
A3.3.2 SUNA cronica
A. Attacchi che soddisfino i criteri A-F per A3.3 SUNA
B. Gli attacchi si ripresentano per > 1 anno senza periodi di remissione o con periodi di remissione di durata < 1 mese
Bibliografia
1. Sjaastad O, Russell D, Hørven J, Bunnaes U. Multiple neuralgiform unilateral headache attacks associated with conjunctival injection and appearing in clusters. A nosological problem. Proc Scand Migr Soc Århus 1978: 31.
2. Sjaastad O, Saunte C, Salvesen R, Fredriksen TA, Seim A, Røe OD, Fostad K, Løbben O-P, Zhao JM. Shortlasting, unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection, tearing, sweating and rhinorrhoea. Cephalalgia 1989; 9: 147-156.
3. Pareja JA, Sjaastad O. SUNCT syndrome. A clinical review. Headache 1997; 37: 195-202.
4. Chitsantikul P, Becker WJ. SUNCT, SUNA and pituitary tumors: Clinical characteristics and treatment. Cephalalgia 2013; 33 (3): 160-170
5. Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders: 2nd Edition. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1): 1-160.
6. Cohen AS, Matharu MS, Goadsby PJ. Shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing (SUNCT) or cranial autonomic features (SUNA) – a prospective clinical study of SUNCT and SUNA. Brain 2006; 129: 2746-2760.
7. May A, Bahra A, Büchel C, Turner R, Goadsby PJ. Functional MRI in spontaneous attacks of SUNCT: short-lasting neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing. Ann Neurol 1999; 46: 791-793.
8. May A, Bahra A, Büchel C, Frackowiak RSJ, Goadsby PJ. Hypotalamic activation in cluster headache attacks. Lancet 1998; 352: 275-278.
9. Cohen AS. Short-lasting neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing. Cephalalgia 2007; 27: 824-832.
10. D’Andrea G, Granella F, Cadaldini M. Possibile usefulness of lamotrigine in the treatment of SUNCT sindrome. Neurology 1999; 53: 1609.
11. Leone M, Rigamonti A, Usai S, D’Amico D, Grazzi L, Bussone G. Two new SUNCT cases responsive to lamotrigine. Cephalalgia 2000; 20: 845-847.
12. Graff-Radford SB. SUNCT syndrome responsive to gabapentin (Neurontin). Cephalalgia 200; 20: 515-517.
13. Dora B. SUNCT syndrome with dramatic response to oxcarbazepine. Cephalalgia 2006; 26: 1171-1173.
14. Leone M, Franzini A, D’Andrea G, Broggi G, Casucci G, Bussone G. Deep brain stimulation to relieve drug-resistant SUNCT. Ann Neurol 2005; 57: 924-927.
15. Lampl C, Katsarava Z, Diener H-C, Limmroth V. Lamotrigine reduces migraine aura and migraine attacks in patients with migraine with aura. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76: 1730-1732.
16. Attal N, Cruccu G, Haanpää M, Hansson P, Jensen TS, Nurmikko T, Sampaio C, Sindrup S, Wiffen P. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006; 13: 1153-1169.